- Aristotele
- Hempel e Oppenheim
- Controesempi alla teoria di Hempel-Oppenheim
- La legge di natura
- La spiegazione funzionale
- Leggi di natura e scienze cognitive
- Il modello come struttura dell'explanandum
- Effetti e capacità in psicologia
- Paradigmi di spiegazione psicologica
- La teoria BDI
- Il gap di Leibniz
- Il ruolo delle neuroscienze
- L'evoluzionismo
- Il computazionalismo
- Fodor e il computazionalismo
- Il connessionismo
- La cognizione situata
- Bibliografia
| La
spiegazione funzionale
Caratteristico della spiegazione funzionale è il fatto che l'evento oggetto di spiegazione solitamente non è l'unico possibile esito di quelle che sono le sue cause in termini di necessità funzionale. Così, ad esempio, l'uomo mantiene l'omeostasi termica disperdendo calore con il sudore; il cane, invece, ansimando vigorosamente. Così, il cuore non è l'unico mezzo che consente di garantire l'apporto di ossigeno ai tessuti periferici; durante gli interventi cardiochirurgici, la circolazione extracorporea consente un identico risultato. Si tratta di quelli che vengono chiamati equivalenti funzionali: lo stesso fine, che ha valore di spiegazione funzionale, può tuttavia essere raggiunto con mezzi diversi. Osserviamo allora - come già aveva ammesso Hempel, e come W.C. Salmon (1989) ha ulteriormente sottolineato - che nel caso della spiegazione funzionale si realizza un'inversione di condizioni rispetto al modello DN: mentre in quest'ultimo l'explanans è logicamente sufficiente per asserire l'explanandum, nella spiegazione funzionale è l'explanandum che di per sé è logicamente sufficiente ad asserire l'explanans. Ciò bastava, secondo Hempel, a negare il titolo di spiegazione a questo tipo di argomentazioni: e infatti non a caso l'articolo di Hempel del 1959 dedicato al problema reca il titolo «The Logic of Functional Analysis» (e non «Explication»). I successivi contributi di Wright (1976) e Bigelow e Pargetter (1987) hanno approfondito la nozione di conseguenza e di propensità, accentuando l'impostazione evoluzionistica e anche propriamente selettivistica della nozione di spiegazione funzionale, un aspetto che verrà ripreso in alcuni specifici modelli di spiegazione psicologica. Non c'è dubbio però che è diventato sempre più chiaro come, in questo tipo di spiegazione, l'explanandum sia al centro dell'attenzione, in un ribaltamento del ragionamento che poco ha a che fare con il metodo nomologico-deduttivo. La questione adesso è: come dovremo intendere la legge di natura nel contesto della spiegazione funzionale? Se il concetto di legge era già critico per le scienze dove la statistica non permetteva la deduzione certa di un evento a partire dalle premesse, tanto più questo concetto assume caratteristiche particolari nelle scienze biologiche, e in particolare nelle scienze cognitive. |
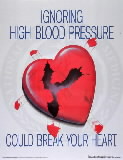 Come
si è visto esaminando
Come
si è visto esaminando