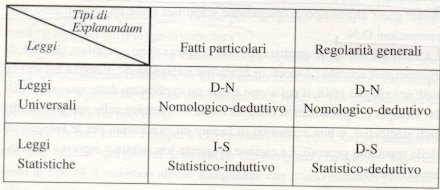- Aristotele
- Hempel e Oppenheim
- Controesempi alla teoria di Hempel-Oppenheim
- La legge di natura
- La spiegazione funzionale
- Leggi di natura e scienze cognitive
- Il modello come struttura dell'explanandum
- Effetti e capacità in psicologia
- Paradigmi di spiegazione psicologica
- La teoria BDI
- Il gap di Leibniz
- Il ruolo delle neuroscienze
- L'evoluzionismo
- Il computazionalismo
- Fodor e il computazionalismo
- Il connessionismo
- La cognizione situata
- Bibliografia
| L'articolo di
Hempel e Oppenheim: «Studies in the Logic of Explanation»
(Philosophy of Science 15, pp. 135-175, 1948): la spiegazione
nomologico-deduttiva
Hempel e Oppenheim affrontarono il problema della spiegazione scientifica per gli explananda costituiti da fatti particolari, spiegazione che può essere costituita solo da una argomentazione deduttiva a partire da una o più leggi generali (la cosiddetta legge di copertura) applicata a condizioni empiriche particolari. La premessa cioè è costituita da una serie di enunciati, comprendenti almeno una legge generale, che danno origine alla catena deduttiva la quale porta alla conclusione che un determinato evento si verificherà a partire da quelle premesse (spiegazione potenziale); la spiegazione è vera semplicemente se sono veri gli enunciati presenti nelle premesse. Per la presenza della legge (in greco: nòmos) di copertura e per la struttura argomentativa della spiegazione, questo modello viene comunemente chiamato nomologico-deduttivo (o DN). Era ben chiaro ai due autori che la spiegazione DN poteva soddisfare solo un numero limitato di occasioni di spiegazione: inoltre veniva accennato, ma non trattato, il problema delle spiegazioni statistiche, per le quali nessuna legge universale priva di eccezioni è disponibile, ma solo leggi statistiche legate alla probabilità.
La spiegazione DN come descritta da Hempel e Oppenheim è stata sottoposta a numerose critiche, fra le quali vanno ricordate quelle relative alla definizione degli enunciati legisimili e alla reale efficacia esplicativa della legge universale. In particolare, una legge universale può essere considerata la descrizione della regolarità con cui si realizza un dato fenomeno: essa non dice perché questi si verificano. In altri termini, la legge può essere considerata un explanandum, e non può quindi svolgere il ruolo di un explanans.
|